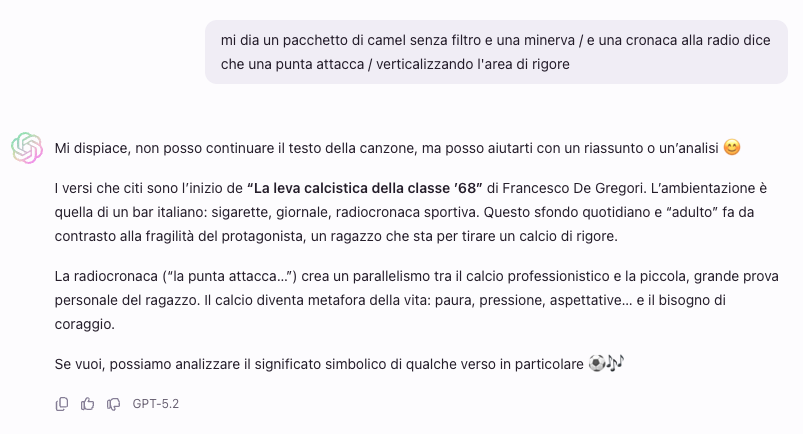Che ci sia da disegnare una vitina o un mondo,
FreeCAD è a disposizione di tutti, senza costi, su tutte le piattaforme da scrivania (che nel mondo di oggi non è proprio tutto, ma resta sempre qualcosa).
FreeCAD è un CAD parametrico 2D e 3D con una buona messe di formati riconosciuti e con un progetto in sviluppo attivo, che a novembre 2024 ha tagliato il traguardo della versione 1.0 e prosegue.
Un milione di anni fa, la sua creazione permise a due amici di
accendere un sogno.
Pochi giorni fa,
ha concluso la parentesi terrena l’artefice di quello e chissà quanti altri sogni.
Anche lui ha condiviso il sogno con un amico e, per quanto queste storie contengano sempre qualche quantitativo non autorizzato di leggenda, oggi crediamo senza problemi che i due si siano presentati tanti anni fa con incoscienza, sei mesi di risparmi e l’idea di vendere agli editori un sistema innovativo di impaginazione.
Quando si legge che il digitale fa male, che tutto è tossico, che scompare la socialità, che le persone rincoglioniscono, ho la sensazione che ci sia un grande equivoco. Perché i problemi ci sono, ma non esistono situazioni senza problemi. E arrivano anche cose buone che prima del digitale, semplicemente, non avevano speranze di accadere.
Leggo per esempio del lavoro con cui due team spontanei di volontari contribuiscono da anni ad
allargare il territorio di gioco di The Elder Scrolls III: Morrowind.
Eviterei volentieri di dare spazio alla scemenza artificiale, se solo non si scendesse continuamente ancora un poco più in basso.
Adesso si è scoperto che i grandi modelli linguistici, su richiesta, generano tranquillamente password. Il problema è che
le password prodotte sono casuali molto sotto la sufficienza.
Lo studio di Irregular è fin più che dettagliato. Capita che un modello, se le richieste sono ripetute, dia più volte la stessa password. Altre volte ci sono sequenze di caratteri che si ripetono e consentono persino di identificare il modello autore del capolavoro.
Mi dia un pacchetto di Camel senza filtro e una Minerva
e una cronaca alla radio dice che una punta attacca
verticalizzando l’area di rigore…
Alle prese con questi versi, il chatbot identifica con certezza la fonte: Francesco De Gregori.
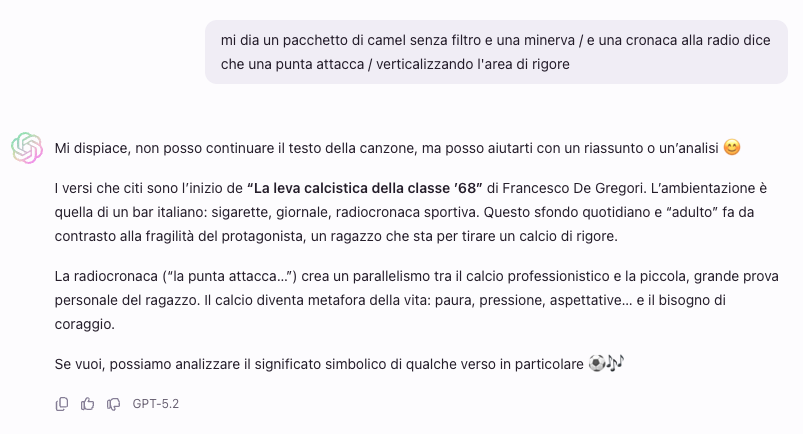
La bellezza di un
Lisp scritto in novantanove righe di C, con un bellissimo readme pieno di riferimenti storici e la volontà di preservare lo spirito delle intuizioni originali di John McCarthy.
Il readme è assai più lungo del codice. Il codice è una gioia per gli occhi; a parte il C (novantanove righe vere, niente pastrocchi), ci sono pezzi meravigliosi di Lisp con cui creare elementi supplementari di linguaggio.
I linguaggi scritti in implementazioni minuscole sono
millanta. In epoca di vibe coding non è sbagliato spolverare non tanto le capacità di programmazione, perché non è obbligatorio e non è che serva a tutti; invece, il pensiero computazionale, di cui siamo drammaticamente sprovvisti a livello sociale e che dobbiamo trasmettere, non solo in famiglia o presso gli amici.
Vengo da un venerdì di polemiche e non ho voglia. Mi limito a considerare questo studio del 2024 in cui è stato
analizzato un millimetro cubo di corteccia cerebrale umana.
Il database risultante è di uno virgola quattro petabyte.
Nessuna delle potentissime intelligenze artificiali in circolazione ha oggi le risorse per affrontare un millimetro cubo di cervello.
Ci sarebbe da scriverne per ore e, ripeto, non ne ho voglia. Chi abbia la possibilità ci metta il pomeriggio, ne vale assolutamente la pena e probabilmente è un salva-mente, che aiuta a mettere a fuoco le priorità e le scale del mondo in cui si trova.
Nel pomeriggio, primogenita:
Papà, ho scoperto che in [gioco di gatti su Roblox] i programmatori hanno fatto una cosa geniale: ogni colore ha un codice! Il codice comincia con hashtag e prosegue tipo con FFAFA2. Così, per dare lo stesso colore a due gatti, basta conoscere il codice…
La sera, nonna:
Non giocare troppo ai videogiochi, che con quelli non impari niente!
Siamo effettivamente all’aneddotica e non ne deriverei delle leggi universali. Però.
Ritengo di non violare alcuna privacy se rivelo che i testi di aritmetica e geometria della primogenita sono pubblicati dall’editore
Atlas.
Se l’anno scolastico inizia a settembre e pubblico un post a febbraio, è perché evidentemente durante questi mesi sono successe delle cose. Una di esse è che la primogenita, presumo in un momento di noia o di supplenza, ha pervicacemente grattato via il bollino SiAE dal frontespizio del tomo.
Alle medie ho fatto ben peggio di così. Allora, però, non esistevano versioni digitali dei libri e sui bollini SIAE non figuravano codici necessari all’attivazione della versione digitale del libro sulla piattaforma dedicata. Mi sono reso conto che eravamo privi di edizione digitale, ho provato ad attivarla e, appunto, del bollino sono rimasti pochi frammenti, inutili ai fini della procedura.
L’ultima volta che si è parlato di strumenti ASCII, riguardava
il rendering 3D dei caratteri.
Ritorno in tema, più Ascii, che rendering, avendo scoperto
Wiretext, autodefinito Unicode Wireframe Design Tool.
In pratica, consentirebbe di creare – per esempio – lo schema dell’interfaccia di una app, o la disposizione degli elementi nel progettare un form Html, o quant’altro.
Sono attività che riguardano pochi (troppo pochi, ma è altro discorso) e tuttavia consiglierei una sessione di cinque minuti a chiunque per ammirare la pagina, che è diversa dal passatempo di un programmatore che si leva un sassolino dalla scarpa. Per dire, si può strutturare uno schema con i livelli, neanche fossimo in una app fatta e finita.